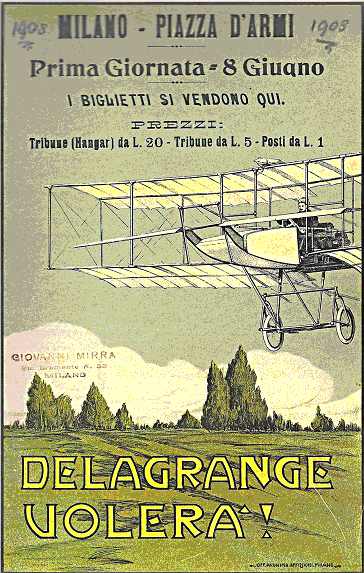
Manifesto pubblicitario dei voli di
Delagrange a Milano (giugno 1908)
Strano evento quello del 18 giugno 1908, il primo volo di un
aeroplano a motore compiuto a Milano dal francese Leon Delagrange, e strano
centenario quello che è ricorso quest’anno.
Abbiamo commemorato in effetti un avvenimento che non segna
una particolare gloria nazionale, né un record assoluto. Il suo ricordo è sicuramente
surclassato da eventi più eclatanti avvenuti qualche anno prima o dopo, per
esempio il primo volo a motore dei fratelli Wright del dicembre 1903 (che tutti
conoscono) o il Circuito Aereo di Milano del settembre 1910, che rimase a lungo
nella memoria cittadina anche per la tragica morte dell’aviatore di origine
peruviana Geo Chavez, dopo la sua temeraria traversata aerea delle Alpi. (Vedi pagina)
I brevi voli di
Delagrange, fatti ancora tra molte incertezze ed inconvenienti degni quasi di
quel vecchio e canzonatorio film intitolato “Quei temerari sulle loro macchine
volanti”, non furono in fondo una gran cosa, ma l’evento fu comunque
importante: dimostrò al grande pubblico milanese, da tempo attento e curioso
sui fatti dell’aerostatica, che anche i velivoli più pesanti dell’aria avevano
ormai trovato la loro strada; e non fu solo un evento locale, ma accomunò
Milano, Roma e Torino nello stesso entusiasmo per la caduta di una di quelle
storiche barriere che il “progresso” umano sembrava ormai in grado di abbattere
una dopo un’altra.
Per l’Italia nel suo complesso fu sicuramente un evento
foriero di molte occasioni di sviluppo. Potremmo forse dire, che si aprì un
primo spiraglio nella porta di ingresso allo sviluppo dell’aeronautica
nazionale, ed anche se la porta fu aperta da un francese ciò consentì ai
pionieri italiani che erano pronti a guardare al di là della soglia di iniziare
il loro cammino.
In altra parte del sito i navigatori potranno trovare
qualche notizia sui primordi del volo aerostatico a Milano (Vedi pagina). Qui
vogliamo ricordare che il forte interesse dei milanesi per il volo degli anni
di fine ‘800 è anche documentato dall’uscita del primo numero della rivista
“L’Aeronauta” nel 1896 e dalla fondazione, nel 1897, della Società Aeronautica
Italiana (SAI).
E non si trattava solo di un interesse popolare, di tipo
ludico-sportivo, perché anche i bei nomi del mondo accademico, come il prof.
Giuseppe Colombo del Politecnico, si interessavano molto della materia.
Comparvero infatti anche i primi trattati scientifici in italiano sul volo: nel
1895, “Teoria del volo”, scritto dal professore torinese Aristide Faccioli, ma
pubblicato a Milano da Hoepli, e nel 1903 la memoria dei fisici milanesi Finzi
e Soldati, su “Esperienze sulla dinamica dei fluidi”.
Nei primi anni del ‘900 il grande pubblico milanese (e
italiano) ebbe un’altra grossa occasione di accostarsi all’aerostatica durante
la grande Esposizione Universale del 1906 (fu l’EXPO 2015 di un secolo fa), in
occasione della quale visitò numeroso il grande padiglione e la vasta arena ad
essa dedicati. L’esposizione fu anche l’occasione di diverse competizioni ed imprese; per
esempio il milanese Celestino Usuelli volò fino ad Ancona e attraversò le Alpi
in pallone (Usuelli in quegli anni costruì e fece volare anche diversi
dirigibili di discrete prestazioni).
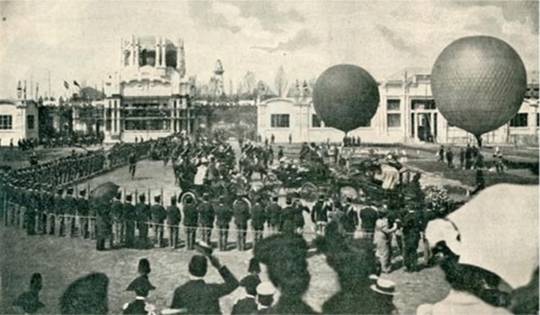
Fig.1 - Palloni alla Esposizione
Internazionale del 1906
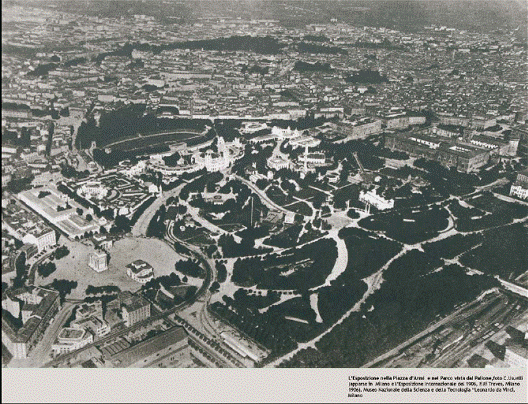
Fig.2 - Vista da un pallone
dell’aerea espositiva al Parco Sempione dell’EXPO 1906
Velivoli fra USA e Francia
Per quanto riguarda i più pesanti dell’aria azionati da
motori, benché per noi oggi sia chiara la primogenitura del volo dei fratelli
Wright, bisogna ricordare che le notizie su questo evento arrivarono in Europa
con notevole ritardo, e quello che i due fratelli erano realmente in grado di
fare divenne evidente solo nell’agosto del 1908, quando Wilbur Wright venne
finalmente in Francia. I due fratelli erano stati loro stessi piuttosto restii
a dare pubblicità ai loro velivoli fin quando non erano stati abbastanza sicuri
di poter difendere la loro invenzione con dei brevetti. Le prime notizie a
stampa di un certo rilievo erano quindi comparse solo all'inizio del 1905 (il
primo resoconto era casualmente comparso su una rivista di apicultura), e solo
verso la fine del 1906 la rivista scientifica "Scientific American" ne
aveva fatto qualche accenno.
L’attenzione degli italiani era quindi inevitabilmente
rivolta a quel che succedeva in Francia, dalla quale arrivavano facilmente e
prontamente notizie di continui progressi nel volo a motore.
Comunque anche a Parigi i primi balzi a motore erano stati
spiccati da un americano (o meglio da un sud-americano), il play-boy brasiliano
Alberto Santos-Dumont, figlio di un ricchissimo magnate del caffè, che non
contento del suo lavoro pionieristico e dei successi ottenuti fra 1900 e 1901
nel campo dei dirigibili, qualche anno dopo si era lanciato alla ricerca di
primati anche con i più pesanti dell'aria.
Nell'autunno del 1906 con il suo goffo biplano era riuscito a
compiere dei voli rettilinei, prima di qualche decina e poi di qualche
centinaio di metri. Ma era chiaro allo stesso Santos-Dumont che quel velivolo
non era il più adatto a compiere il volo di 1 km in circuito chiuso per il
quale il magnate del petrolio Deutsch de la Muerte e il ricco avvocato e sportivo
Archedeacon, uno dei fondatori dell’ Aero Club de France, avevano messo in
palio un cospicuo premio; tant'è vero che egli si rimise subito al lavoro su un
diverso progetto.
Il 1907 fu un anno cruciale per il volo a motore, perché a
Parigi i pionieri Santos-Dumont, Voisin, Bleriot, ed altri, lavorarono
alacremente per conquistare questo premio. E nella competizione si inserirono
presto due grandi “sportivi” e piloti, Henry Farman e Leon Delagrange.
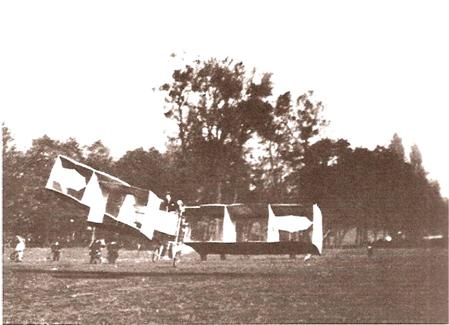
Fig.3 - Il biplano di Santos-Dumont
dei primi voli a motore in Europa (novembre 1906)
Delagrange a Parigi -1907
Leon Delagrange (LD) si era prima appassionato di dirigibili
e aveva poi seguito i tentativi di Santos-Dumont con il più pesante dell’aria. Nel 1905 aveva anche seguito da vicino i timidi tentativi di
Gabriel Voisin e Ernst Archdeacon di far volare sulla Senna degli aerei
libratori al traino di motoscafi.
Dopo i primi successi di Santos-Dumont, egli si convinse che
il più pesante dell’aria era fattibile; nel suo studio di artista elaborò delle
idee su un aeroplano che pensò di farsi costruire, mettendosi per questo in
contatto con i fratelli Voisin, a cui presentò il suo progetto di aereo. Essi
lo giudicarono però troppo complicato, ma gli mostrarono il loro progetto di
velivolo biplano. LD ne fu così entusiasta che ordinò subito la costruzione di
un esemplare (al prezzo di 12.000FF, circa 37.000€ odierni, di cui ¼
all’ordine), che doveva essere consegnato nel febbraio 1907.
Si trattava di un velivolo “a due assi” privo quindi di
alettoni, con una superficie alare di circa 40 mq. Era dotato di un
equilibratore anteriore che ricordava quello del velivolo di Santos-Dumont. Il
motore era l’otto cilindri “Antoinette”, costruito appositamente dall’ingegner
Levavasseur per le applicazioni aeronautiche, dotato di elica spingente
I primi tentativi di farlo volare nel marzo 1907 furono
degli insuccessi. La struttura era troppo fragile e bisognò irrobustirla. Verso fine marzo 1907 l’apparecchio face i primi balzi
abbastanza convincenti e senza rompersi, però ancora nelle mani dei fratelli
Voisin. LD cominciò a scalpitare perché i Voisin glielo consegnassero, in modo
da poter iniziare l’addestramento al pilotaggio sul campo di Bagattelle, alla
periferia di Parigi, sul quale erano in azione oltre ai Voisin, anche
Santos-Dumont e Bleriot. Ma altri test in aprile, non furono ancora sufficienti ad
arrivare ad una configurazione definitiva.
In maggio 1907 si presentò il secondo cliente serio per i
Voisin, Henri Farman, già noto come vincitore di gare ciclistiche e
automobilistiche. Egli, nel giugno del 1907, passò ai fratelli Voisin l’ordine
del suo aereo che avrebbe incorporato una serie di miglioramenti rispetto a
quello di LD, che sarebbero poi stati inclusi anche nel secondo aeroplano di
LD.
In quel periodo dall'amicizia fra LD, Farman e Voisin, iniziata
nell’officina dei fratelli Charlese e Gabriel Voisin e sui campi di volo,
nacque l'idea di fondare una nuova associazione tutta dedicata ai più pesanti
dell'aria (l’esistente Aero Club si occupava prevalentemente di palloni e
dirigibili). Essi fondarono quindi l’Aviation Club de France, che ebbe il motto
“volo sicut volo” (volo come voglio) e venne inaugurato ufficialmente il 5
ottobre 1907.
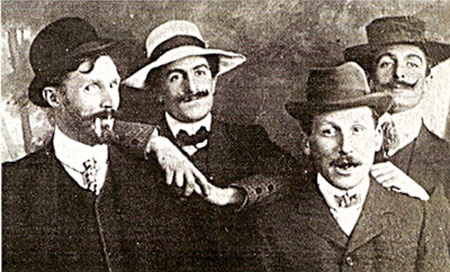
Fig.4 - Farman, i fratelli Voisin e Delagrange (1907)
LD intravide presto
anche il lato commerciale della sua passione e fondò la “Compagnie d’Aviation”,
sotto i cui auspici volerà l’anno dopo in Italia.
Intanto l’ambiente sportivo-aeronautico si scaldava e
venivano lanciate scommesse da 5000 FF su chi fosse stato in grado di
effettuare un volo da almeno 500
m prima di febbraio 1908. Ma soprattutto c’era in ballo
anche il favoloso premio da 50.000FF messo in palio da Archdeacon- Deutsch De la Muerthe per un volo di
almeno 1 km
su percorso chiuso.
LD cominciò finalmente a volare sul suo aeroplano al posto
dei Voisin ai primi di novembre; il 5 novembre ebbe però il primo incidente,
tentando una piccola virata. La parte anteriore del velivolo di LD risultava
distrutta e non valeva pertanto la pena di ricostruirlo, ma LD, per nulla
scoraggiato, ordinò subito un nuovo aereo, che sarà il Delagrange 2.
Per il momento LD rimase comunque appiedato; ne approfittò
Farman che continuò ad allenarsi, riuscendo il 13 gennaio 1908 a fare un volo di più
di 1 km
di fronte alla commissione ufficiale ed a vincere il premio Deutsch-Archdeacon.
Delagrange a Parigi, inverno 1908
Verso il 20 gennaio 1908 anche LD cominciò di nuovo a volare
col suo nuovo aeroplano Delagrange 2.
L’apparecchio era sempre un due assi, ma l’equilibratore
anteriore era stato modificato; restava invece quasi identico lo stabilizzatore
posteriore. Il velivolo si pilotava con un volante che sterzava per dare
destra/sinistra, e si tirava per cabrare; la superficie alare era sempre di
circa 40 m2,
l’apertura alare di circa 10 m,
ed il peso a vuoto era salito a quasi 500 kg. Il motore era sempre l’Antoinette 50
CV, 8 cilindri.
In marzo 1908 LD riprese il suo allenamento e conquistò il
piccolo premio che l’Aero Club aveva istituito per quelli che facevano più di 200 m di volo. Ma Farman per
il momento rimane il più bravo, compiendo il 21 marzo un volo di più di 2 km. La competizione
amichevole fra i due piloti continuava di giorno in giorno. L’ 11 aprile LD si
riscattò, volando per 4 km
e battendo il precedente record di Farman.
Il 1 maggio LD dopo aver volato più volte, verso sera ebbe
un incidente: nel tentativo di evitare un gruppo di spettatori urtò un
automobile e il suo velivolo venne severamente danneggiato. Dovette quindi
essere notevolmente riparato, tant’è vero che quello con cui si presentò in
Italia era marcato Delagrange 3.
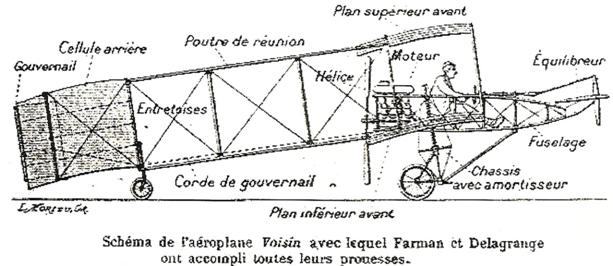
Fig.5 - Schema del velivolo biplano Delagrange 2
(gennaio 1908)

Fig.6 - Il motore Antoinette
conservato al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano

Fig.7 - Volo record di Delagrange a
Parigi (aprile 1908)
La tournée italiana di Delagrange: prima tappa Roma
Nel marzo 1908 era stata formata nell’ambito della Società
Aeronautica Italiana (che aveva la sede principale a Roma) un comitato ed una
delegazione da inviare in Francia con l’incarico di organizzare la venuta in
Italia, per dimostrazioni di volo a Roma, Milano e Torino, di uno dei piloti
che in quel periodo si erano più distinti a Parigi.
La delegazione era presieduta dall’ingegnere torinese Carlo
Montù, che fu poi parlamentare, dirigente sportivo e presidente del CONI,
mentre tra i membri milanesi del comitato figuravano i più bei nomi cittadini
tra i quali Alberto Pirelli, Gabrio Sormani, Giovanni Visconti di Modrone,
Arturo Mercanti, Mario Crespi.
Quando la commissione italiana
incontrò LD a Parigi, nel marzo 1908, i due aerei Voisin, il suo e quello di
Farman, apparivano i più validi in azione sui campi parigini, ma LD non aveva
ancora fatto faville. I commissari che lo scelsero fecero dunque una scommessa
sui progressi che LD avrebbe potuto rapidamente fare, ed ebbero fiuto. Ma non è
chiaro perché scelsero LD e non Farman. Probabilmente si trattò di una
questione economica in quanto Farman si dimostrò anche in seguito più esoso. LD
fu comunque ingaggiato con una notevole offerta che gli fruttò, per l’intera
tournée un guadagno di 50.000 FF (circa 150.000€ attuali), al netto delle
spese.
Due mesi dopo gli accordi con la delegazione italiana LD era
pronto a partire per l’Italia, sotto gli auspici della Compagnie d’Aviation,
la società da lui fondata. La tournée che veniva giustamente definita
“esperimenti di aviazione” (ma non tutti compresero che c’era ancora molto da
sperimentare), sarebbe iniziata da Roma, ma LD avrebbe comunque fatto prima
tappa Milano.
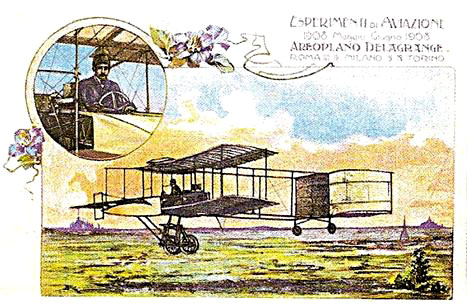
Fig.8 - Manifesto della tournée
italiana di Delagrange (maggio 1908)
LD arrivò in treno a
Milano il 16 maggio, poco prima di mezzogiorno, accolto dai rappresenti della
SAI, della Società Milanese di Aviazione (SMA) e dalla stampa. Alle 14 si recò
alla sede del Touring Club Italiano, dove si erano raccolte quasi 7000 persone
per vederlo e chiedere autografi. Nel pomeriggio visitò la piazza d’armi, ed anche due
ippodromi dove avrebbe potuto volare, concludendo che avrebbe preferito il
vasto terreno della piazza d’armi, che era senza alberi.
Il giorno seguente LD ebbe modo di visitare Milano e davanti
alla statua di Leonardo, in piazza della Scala, gli scappò il commento “gli è
mancato un motore”. Salì anche sul Duomo fino alla Madonnina, e lì disse che
aveva le vertigini, ma che in aeroplano è tutta un’altra cosa.
Venne intervistato dai
giornali con varie domande sui suoi avversari in Francia (disse per esempio che
Bleriot aveva un monoplano che doveva andare troppo veloce, e non era facile
trovare un posto per atterrare). I giornali parlarono di una possibile venuta
anche di Henry Farman in vista di una grande competizione fra i due assi
francesi (dotazione 40.000 lire di premi), ma poi non se ne fece niente perché
Farman chiedeva troppi soldi.
Il 18 maggio LD partì per Roma in treno. Il suo aeroplano
era nel frattempo arrivato in Italia, imballato in grandi casse caricate su più
vagoni. Per non avere problemi erano statati spediti anche la benzina e l’olio. LD era accompagnato da
Gabriel Voisin, dall’ing. Thouvenot, da due meccanici e da Therese Peltier, la
sua compagna, che scriverà un resoconto della tournée per il giornale parigino "Les
Sports".
Il 24 maggio domenica, l’attesa per il primo volo romano,
alimentata dai giornali, era elevata; era prevista anche la presenza del re e
della regina. Il volo era stato annunciato per le 17,30, ma già alle 16 si era
radunata una folla di 100-150.000 spettatori paganti. Ma il vento era forte, a
raffiche. LD non voleva uscire dall’hangar e la folla incominciò e spazientirsi
e agitarsi. Verso le 18 il vento ebbe un calo sensibile e LD poté uscire
dall’hangar col suo apparecchio e fare dei rullaggi veloci a terra; forse si
staccò brevemente da terra, ma poi dovette rinunciare per il vento ancora
troppo forte.
Tra la gente cominciarono accanite discussioni, ha volato,
non ha volato. Ma per la maggioranza che si aspettava evoluzioni come quelle di
un uccello, chiaramente non aveva volato.
Un po’ più tardi LD fece un nuovo tentativo e riuscì a
volare per più di 1 km
a 1m da terra, ma poi rinunciò definitivamente, riportando l’aereo nell’hangar.
La folla, sentendosi ingannata, iniziò a questo punto a lanciare oggetti e ad
avvicinarsi minacciosa all’hangar. Dovette intervenire la cavalleria e LD venne
portato via in automobile.
La folla romana non capì ed alla delusione si associarono
anche alcuni giornalisti e intellettuali. Il poeta Trilussa espresse il suo
disappunto in un sonetto ironico, nel quale diceva fra l’altro:
….pieno de boria s’arzò quanto un mazzo de cicoria…
Ma il pubblico colto capì, e LD ricevette anche fiori e
lettere di scuse.
Lunedì 1 giugno, al mattino presto LD fece un’ultima
riuscita esibizione privata per la regina madre Margherita. A un certo punto un
rinforzo di vento quasi lo scagliò verso la tribuna regale, ma intanto il
motore si fermò ed egli fece un atterraggio brusco, danneggiando un po’ il
carrello.
La regina gli si avvicinò con la sua automobile e lo
complimentò, nonostante il lieve incidente. Mentre lui si inchinava a baciarle
la mano nel salutarla, la regina gli disse che non le sarebbe dispiaciuto in
futuro possedere un aeroplano, quando lo sport dell’aviazione fosse diventato
un po’ più pratico. In serata ci fu il pranzo di gala. Il 2 giugno si
procedette agli smontaggi per la spedizione a Milano. Così si concluse la tappa
romana.
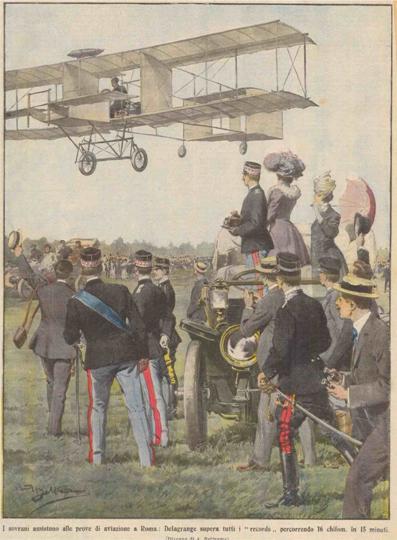
Fig.9 - Delagrange vola a Roma alla presenza dei reali (maggio 1908)
La tournée italiana: Milano
LD arrivò a Milano il 4 giugno. Le sue esibizioni erano
annunciate da numerosi striscioni e manifesti, che titolavano perentoriamente
“Delagrange volerà”, ed anche qui l’attesa era forte.
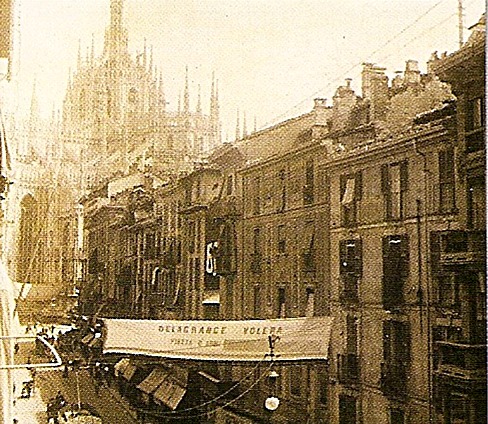
Fig.10 - Striscioni con l’annuncio
dei voli a Milano di LD (giugno 1908)
Il luogo dove LD avrebbe volato era servito due anni prima
per la seconda area espositiva dell’ EXPO 1906 (la prima area espositiva era
situata nell’attuale Parco Sempione). Erano i terreni della nuova piazza
d’armi, un grande quadrato sul quale in seguito fu costruita la Fiera di Milano, e si può
ragionevolmente ipotizzare che il campo di volo coincidesse proprio con la zona
che era stata allora riservata ai palloni; l’area era ancora circondato da
palizzate, e c’erano pure delle tribune. Per l’evento fu approntato un grosso
hangar, dotato di acqua ed elettricità, dove l’aereo venne rimontato.
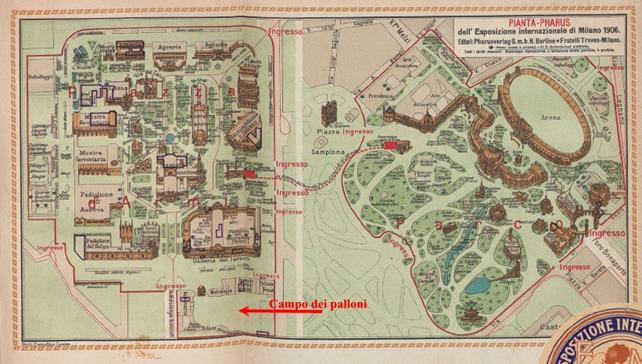
Fig. - 11 Mappa delle due aree
espositive dell’EXPO Internazionale del 1906

Fig.12 - L’aeroplano Delagrange a terra a Milano (giugno
1908)
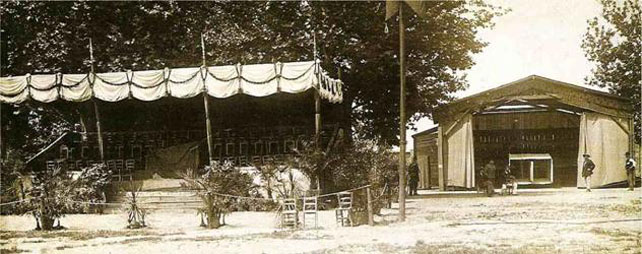
Fig.13 - L’hangar e le tribune per
i voli a Milano di LD (giugno 1908)
Il 7 giugno domenica era prevista una prima esibizione per
un pubblico scelto, ma pioveva a dirotto. L’8 ci doveva essere la prima in
pubblico, tutti i biglietti erano stati venduti, ma c’è ancora maltempo. Il 9
LD compì due giri del campo per un pubblico ristretto.
L’11 era ancora un giorno riservato ai VIP, 500 persone che
avevano pagato una bella cifra per entrare. Ma dopo aver percorso poco più di 1 km, l’apparecchio ricadde
pesantemente e nel brusco atterraggio il carter del motore si danneggiò (sembra
che fosse già incrinato da uno dei voli in Francia, ed ora si era rotto
completamente). Un motore di ricambio arrivò dalla Francia il 16, e venne
rimontato nella notte; la sera del 17 si fecero le prime prove.
Il 18 giugno, in serata, ci fu la prima esibizione pubblica
davanti a circa 25.000 spettatori. LD compì diversi voli, ma non troppo lunghi,
perché il nuovo motore aveva ancora bisogno di messa a punto. A un certo punto
LD ritornò in hangar, ed fu a quel punto che la folla invase il campo per
vederlo da vicino. Il servizio d’ordine, memore dei problemi di Roma, fece
rimanere pilota e assistenti chiusi nell’hangar, ma poi LD uscì fra il grande
entusiasmo. Però per quel giorno non si poterono più fare voli perché il campo
era invaso. Nonostante gli inconvenienti il pubblico milanese gli aveva
dimostrato simpatia e LD fu così rassicurato e riacquistò fiducia di sistemare
le piccole pannes del motore. Comunque anche a Milano non mancarono le malelingue,
come un certo Corradini, che scrisse una composizione in milanese intitolata
"La noeuva machina per volà" nella quale lamentava che i milanesi
fossero fatti imbrogliare, e dove riprendendo un po' il concetto di Trilussa
diceva fra l’altro:
...La gent de
feura la se fissa
credendo de vedel a volà un quai moment
ma a furia de spettà ghe ven la stizza
perché el congegn el sta semper dent,
Delagrange infin el sort,
el spicca un vol insci a foit
che a dil propri senza boria
el va no pusseè alt de la cicoria…
Il 21 giugno al mattino presto c’era ancora vento forte, che
poi però si calmò consentendo a LD di fare dei buoni voli davanti a circa
15.000 spettatori.
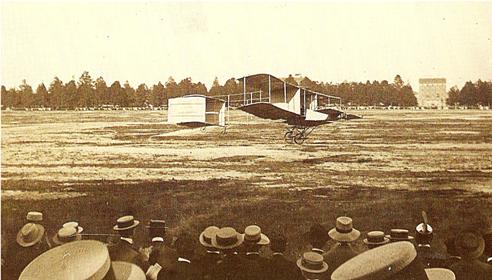
Fig.14 - Il velivolo Delagrange 3 in volo a Milano (18-21
giugno 1908)
Il giorno successivo LD era in forma e tentò di battere il
suo proprio record, percorrendo circa 17 km in 16’ 30”.
Il 23 giugno gli allievi del Politecnico visitarono
l’hangar di LD e l’ing. Thouvenot spiegò loro il funzionamento dell’aeroplano.
In serata LD tentò di conquistare il premio nel frattempo
messo in palio dal sindaco Ponti, per un volo senza soste di ¼ d’ora, ma in un
primo tentativo toccò terra leggermente per un momentaneo calo del motore.
Senza darsi per vinto LD dovette ricominciare tutto da capo, ma quando sembrava
che ce l’avesse quasi fatta finì la benzina, dopo 14’ 27”. Fra l’entusiasmo della
folla LD promise di fare un nuovo tentativo il giorno dopo, ma anche il 24
giugno, nonostante vari tentativi, fino a tarda sera, il record del ¼ d’ora
resistette. L’indomani la troupe levò le tende e partì per Torino, soddisfatta
delle prestazioni e di un pubblico più cordiale di quello romano.
A ricordo dei voli milanesi di LD venne posto un memoriale
molti anni più tardi, in occasione del primo salone aeronautico del 1935. La
stele che tuttora esiste sul fianco del Palazzo dello Sport, recita:
“Da qui un uomo volò quando volare era un sogno. Il sogno
concretato non sia oggi meta, ma sempre stimoli a più alte conquiste.”.

Fig.15 - Stele a ricordo dei volo
di LD, tuttora esistente sul fianco del Palazzo dello Sport, in piazza VI
Febbraio
La tournée italiana: Torino
Il luogo per le esibizioni torinesi fu la nuova piazza
d’armi, un buon terreno se il motore non avesse fatto i capricci; intanto, per
prudenza, la casa costruttrice aveva mandato da Parigi un altro ingegnere.
Il debutto torinese avvenne il 27 giugno, con un motore che
non era peraltro ancora perfettamente a punto, tanto che durante uno dei voli
un calo improvviso di potenza face sbagliare a LD la virata, colpendo con
un’ala un albero e finendo in un fosso. LD venne sbalzato dall’aereo, ma non si
fece male; però il velivolo fu seriamente danneggiato e ci vollero 8 giorni per
ripararlo. Il 5 luglio LD avrebbe dovuto finalmente volare, ma si
verificò una pesantissima grandinata e fu quindi possibile solo un breve volo.
L’8 luglio nel pomeriggio le tribune erano gremite; in
programma c’era anche una visita di quattrocento allievi ingegneri del
Politecnico di Torino. LD compì qualche breve volo, spiegando agli
organizzatori che c’è ancora del vento fastidioso nella zona sud est del
circuito. Finalmente le condizioni migliorarono, e LD poté inanellare giri su
giri, fra l’entusiasmo della folla. Sembrava l’occasione buona per battere il
record di Farman, che in Francia era riuscito a volare per 20 minuti di
seguito, ma a un certo punto il meccanico di LD cominciò a sbracciarsi per
farlo fermare, in quanto si era accorto di una perdita d’acqua dal motore. LD
si fermò per sistemare l’inconveniente, con il pubblico ormai in delirio; LD
espresse allora il desiderio di far volare una seconda persona e fece cenno
alla sua compagna. Therese che salì a bordo, diventando la prima donna al mondo
ad aver fatto un (seppur breve) volo.
Poi LD face salire anche l’ing Montù, capo della delegazione
che era stato a incontrarlo a Parigi facendo con lui un volo un po’ più lungo,
con una mezza virata. La giornata finì solo verso le 21, tra un grande
entusiasmo della gente.
Si concluse così la tournée italiana, ma intanto già
circolavano voci che LD sarebbe ritornato molto presto in Italia, dove aveva
suscitato molte aspettative, per guadagnare un premio da 50.000FF offerto per
chi avesse battuto il record della mezz’ora. Si diceva che LD avrebbe volato
vicino a Pisa, a San Rossore, nella tenuta del re. Anche i livornesi si diedero
da fare, per farlo venire a volare all’ippodromo di Ardenza, ma di questi
ulteriori progetti non se ne fece niente.
Leon Delagrange (1872-1910)
Conclusa questa breve cronaca della tournée italiana di LD,
vorremmo ora tornare un po' sulla figura di questo audace pilota.
Ferdinand Marie Léon Delagrange, nacque a Orleans il
13 marzo 1872 ; era il secondo figlio di un importante industriale laniero
(produzione di coperte, un stabilimento con 400 addetti).
Compì studi regolari a Orleans e dintorni, senza
particolarmente distinguersi, ma con buoni risultati specie nelle materie
artistiche e sportive. Praticò diversi sport.
Il padre avrebbe voluto associarlo all’impresa di famiglia,
assieme al fratello Robert, ma Leon non era molto interessato agli affari,
quanto piuttosto alle macchine dello stabilimento. I suoi interessi si
rivelarono sempre più lo sport, la meccanica e il nascente mondo delle
automobili.
Verso i 18 anni si
dedicò sempre di più alla pittura e alla scultura, e suo padre si rese conto
definitivamente che non avrebbe potuto contare su di lui nell’impresa
familiare.
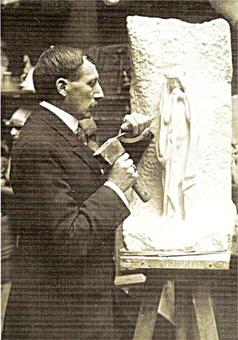 Leon si trasferì a Parigi, e nel 1894 divenne allievo
dell’atelier di Ernest Barrias, che aveva allora una buona reputazione, presso
il quale frequentò una specie di corso preparatorio per l’accesso alla Ecole
National de Beaux-Arts. Nello stesso anno espose le sue prime opere di
scultura al Salon des Artistes Français e l’anno successivo sostenne per
la prima volta, le prove di ammissione alla Ecole, ma non riuscì a
entrare.
Leon si trasferì a Parigi, e nel 1894 divenne allievo
dell’atelier di Ernest Barrias, che aveva allora una buona reputazione, presso
il quale frequentò una specie di corso preparatorio per l’accesso alla Ecole
National de Beaux-Arts. Nello stesso anno espose le sue prime opere di
scultura al Salon des Artistes Français e l’anno successivo sostenne per
la prima volta, le prove di ammissione alla Ecole, ma non riuscì a
entrare.
A Parigi LD incontrò
Therese Peltier, che aveva già conosciuto da più giovane a Orleans prima che
lei contraesse uno sfortunato matrimonio; anche lei era appassionata di
scultura, e fra i due iniziò una relazione.
LD lavorò molto ed espose alcune sue opere nel 1896 e nel
1897, ma un secondo tentativo di farsi ammettere alla Ecole, andò ancora
a vuoto. Da allora LD non frequentò più, se non sporadicamente la scuola, ma
grazie alle risorse familiari, aprì un suo atelier, in Rue Fontaine 14, vicino
a Montmartre. Intanto la sua attrazione per macchine e motori si rafforzava e
si cominciò a vederlo girare al Bois de Boulogne con un quadriciclo
Delaugére, insieme ad altri appassionati di motori.
Nel 1898 e 99 Leon espose ancora al Salon des Artistes
Français. Nel suo atelier lavorava prevalentemente su sculture di piccole
dimensioni, che realizzava in vari materiali.
Nel 1900 divenne membro
della Società des Artistes Français. Negli anni successivi, gli anni della belle
epoque, LD condusse una vita brillante, divisa fra lavoro d’artista e
attività sportive e mondane; ebbe modo di frequentare personalità illustri, e
di cominciare ad appassionarsi oltre che alle automobili anche ai dirigibili e
agli aeroplani, che sarebbero poi divenuti la sua principale passione ed
attività. Il 1907, l’anno dell’acquisto del suo primo velivolo, fu l’ultimo in
cui espose ancora le sue opere ed in cui accettò commissioni artistiche
significative, come quella per un busto del barone de la Muerthe, magnate del
petrolio e mecenate dell’aeronautica, che frequentava spesso il campo di
Bagattelle, terreno di prova degli aviatori parigini.
Le imprese italiane di LD furono molto seguite dalla stampa
francese: l’Auto, Le Figaro, Les Sports e Le Matin pubblicarono vari articoli.
La fama di LD crebbe moltissimo tanto che la sua famiglia a Orleans, che prima
lo ha osteggiato, si abbonò a l’Argus de la Presse, per raccogliere
tutte le citazioni di giornali che parlavano di lui.
In particolare il primo volo di una donna aveva scatenato la
fantasia dei giornalisti e la curiosità della gente, come si vede in questa
vignetta di qualche tempo dopo l’impresa torinese. La didascalia dice:
Sospiri di vergine: sempre in aria, vola come un angelo, dio
perché non sono io la donna di Delagrange.
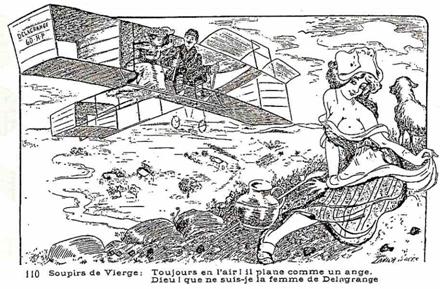
Fig.17 - Vignetta sul volo della
prima donna sul velivolo di Delagrange (luglio 1908)
Il 20 luglio 1908, dopo la tournée italiana LD tornò di
nuovo sul campo di volo di Issy-les Moulineaux per nuove prove, modifiche e
perfezionamenti del suo velivolo.
La vita di LD divenne un susseguirsi di tournèe, gare, e
manifestazioni aeree, di cui intanto era scoppiata una vera e propria febbre
europea. Queste manifestazioni erano improvvisamente diventate più ricche e
stimolanti dopo che gli aviatori francesi avevano avuto modo di confrontarsi
direttamente con quel che sapevano fare i fratelli Wright, che nell’agosto del
1908 erano arrivati finalmente in Europa. Il resto del 1908 e il 1909 fu dunque
per LD tutto un susseguirsi di partecipazioni a gare e manifestazioni in
Francia, Belgio, Germania, Inghilterra, nelle quali cominciarono a circolare
anche i nomi degli altri pionieri che fecero la storia della prima aviazione:
Bleriot, Latham, Rougier, ecc.
Nel 1909 dopo aver inutilmente cercato di imparare a volare
col biplano Wright, LD decise di passare su un altro velivolo francese, il
monoplano Bleriot XI, che aveva sicuramente caratteristiche e prestazioni
superiori ai suoi precedenti velivoli. Con questo apparecchio volò, fino
all’incidente mortale del 4 gennaio del 1910, all’aerodromo di Croix-d’Hins,
vicino a Bordeaux quando un cedimento strutturale stroncò prematuramente la sua
breve, romantica vita.

Fig.18 - Delagrange in tenuta
sportiva (1908)
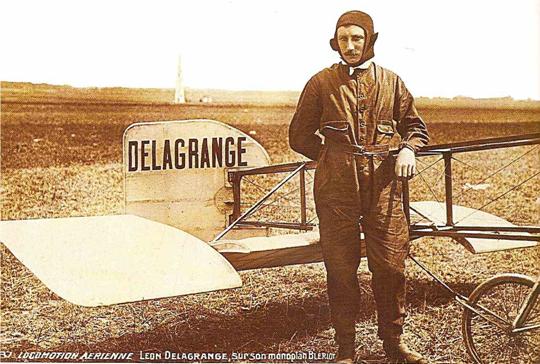
Fig.19 - Delagrange in tuta di
volo accanto al suo nuovo velivolo Bleriot XI (1909)
Una splendida eredità
Già nell’ottobre del 1908 comparvero sulla stampa milanese a
firma di Arturo Mercanti, presidente del TCI, le prime idee per un circuito
aereo a Brescia, da realizzare l’anno successivo, mentre nel gennaio del 1909, avvenne
il primo tentativo di volo a Torino di un velivolo triplano realizzato da
Aristide Faccioli e pilotato da suo figlio; questi primi voli non andarono
bene, ma furono poi ripetuti con successo tra giugno ed agosto dello stesso
anno.
Nell’aprile del 1909, Wilbur Wright fu a lungo ospite
dell’esercito italiano a Roma Centocelle; qui un altro importante pioniere e
costruttore di velivoli, Mario Calderaia, ufficiale di marina, imparò a volare
col biplano Wright e ricevette il primo brevetto italiano di pilota. Da questo
velivolo venne anche effettuata la prima ripresa cinematografica aerea della
storia.
L’estate del 1909 richiamò ancora l’attenzione di tutti
sulla Francia e su avvenimenti che hanno fatto la storia dell’aeronautica
mondiale: il 25 luglio Bleriot attraversò la manica con il suo monoplano munito
di motore Anzani, mentre nell’agosto si svolse il primo grande raduno aviatorio
europeo, il circuito di Reims. A questa gara fece seguito con non minore
risonanza il circuito di Brescia, svoltosi in settembre nella piana di
Montichiari. A questa competizione, che fu vinta dall’americano Glenn Curtiss, partecipò
anche Calderara che vinse vari premi con un biplano Wright munito di motore
italiano REBUS, sul quale portò in volo anche G. D’Annunzio, il poeta e
scrittore che da quel momento divenne grande appassionato del volo.
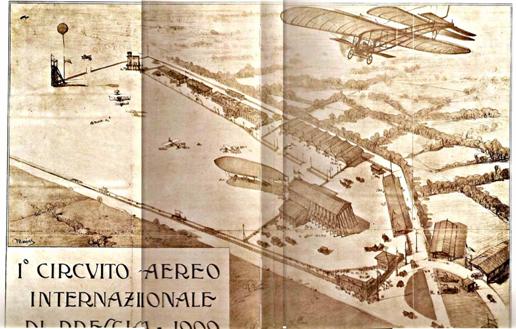
Fig.20 - Catalogo del Circuito
Internazionale di Brescia (settembre 1909)
Nel novembre dello stesso anno si tenne a Milano, presso
l’Hotel Corso (poi teatro Trianon), la 1^ Mostra Italiana di Aviazione,
organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Sempre a Milano, l’editore Sonzogno
lanciò la rivista “L’Aviatore Italiano”.
Anche nel campo dei dirigibili si fecero passi in avanti: in
novembre compì il primo volo il dirigibile F1 Città di Milano di Enrico
Forlanini, che con questa macchina in dicembre sorvolò il Duomo, fra grandi
manifestazioni di entusiasmo popolare.
Nell'anno accademico 1909-1910 il Politecnico di Milano istituì il primo corso
libero di aeronautica, tenuto dal prof. Giorgio Finzi, e l'ingegnere trentino Gianni Caproni fece le sue prime
esperienze di volo, con un aeroplano di sua concezione, nella brughiera di
Malpensa. A maggio si svolse il circuito aereo di Verona, ed a settembre il
grande Circuito Aereo della Città di Milano, a cui si è già accennato, dotato
di ricchissimi premi, al quale era anche abbinata la gara di traversata delle
Alpi. Per consentire lo svolgimento di questa manifestazione fu realizzato,
alla periferia est della città, “l’aerodromo di Taliedo”, che avrebbe fino agli
anni ’30 costituto il nucleo del primo aeroporto milanese. (Vedi pagina)
In occasione di questa manifestazione il Touring Club
pubblicò a Milano il primo “Annuario dell’Aeronautica”, una pubblicazione che
per diversi anni a seguire costituì lo specchio della tecnica aeronautica
italiana e di un mondo dello sport e del tempo libero nel quale i nostri
bisnonni ebbero occasioni di dimostrare il loro coraggio ed ardimento, in
un’epoca ricca e spensierata, nella quale la tecnica aeronautica fece
rapidissimi progressi, dei quali purtroppo molto presto anche la guerra si
sarebbe impossessata.
Riferimenti
Olivier e Yolande
Delagrange, Leon Delagrange. Le “Dandy” volant. Edition LARIVIERE, 2003
G. Apostolo, M.
Pagliano, Il volo a Milano. Ed. a cura “Istituto G. Pini”, 1998
G. Apostolo, R.
Abate, Ali lombarde, Ed. a cura di SEA, 1993
A. Marchetti, Alberto
Santos Dumont, Ed. Logisma, 2003
F. Valli, A.
Foschini, Il Volo in Italia, Ed. Aeronautica, 1939
Civica Raccolta Bertarelli
Civico Archivio
Fotografico di Milano