|
Con la sconfitta dei Torriani a Desio (1277) e l’ingresso a
Milano dell’arcivescovo Ottone Visconti inizia la transizione del potere dal
Comune alla Signoria che si concluderà con la piena presa di possesso da parte
dei Visconti della città di Milano e in seguito delle altre città lombarde. Il
mutamento della forma del potere da “popolare” a “ducale”, da “repubblicano” a
“monarchico”, è accompagnato dallo spostamento di sede dal Broletto Nuovo
nell’attuale piazza Mercanti all’area dove oggi sorge il Palazzo Reale.
Ottone, in quanto arcivescovo, va a stabilirsi nella sede
arcivescovile accanto a S. Maria Maggiore e sistema il nipote Matteo, nominato
Capitano del popolo, accanto a sè nei palazzi pubblici, mai del tutto
abbandonati, del Broletto Vecchio, adiacenti al palazzo arcivescovile e ad esso
collegati da un passaggio aereo. Ottone e Matteo Visconti considerarono subito
i beni arcivescovili come beni di loro proprietà compresa l’antica area del
Broletto dell’Arcivescovo che andava da piazza Fontana a via Rastrelli.
Alla morte di Ottone, nel 1295, un provvidenziale incendio
spinge Matteo a ristrutturare il Broletto Vecchio, ormai diventato il suo
palazzo, ampliandolo grazie all’acquisto delle case dei Della Fiamma.
L’incrinarsi della robustezza della sua posizione dopo la morte dello zio, è
rivelata anche dalla nuova torre che Matteo costruisce accanto al palazzo.
Nel
1300, Galeazzo, figlio di Matteo, sposa Beatrice d’Este, una ricca vedova con
una bambina di 8 anni. Le nozze sono celebrate a Modena, poi gli sposi danno
una grande festa nel Broletto Vecchio che dura otto giorni di seguito con più
di mille persone. Tutto a spese della Comunità di Milano.
Le vicende dei primi decenni del Trecento sono molto
travagliate con il temporaneo ritorno dei Torriani (dal 1302 al 1311) e il
definitivo consolidarsi dei Visconti come signori di Milano, di nuovo con
Matteo e poi con Galeazzo e suo figlio Azzone, signore di Milano dal 1329.
In questo periodo, comunque, il palazzo del Broletto Vecchio
resta sempre sede del Signore, mentre gli edifici continuano ad essere
fortificati assumendo l’aspetto di un castello. Con la signoria di Azzone
avvengono le trasformazioni più vistose che hanno meravigliato i contemporanei
e che ci sono state descritte con toni entusiastici da Galvano Fiamma.
Il Palazzo di Azzone
Nei dieci anni della signoria di Azzone Visconti la città
viene trasformata profondamente con interventi sulle mura, sulle porte e sui
canali. Anche la piazza centrale è oggetto di un programma di abbellimenti che
verranno descritti nella lezione sull’evoluzione della piazza. L’evento però
più significativo è proprio la costruzione del Palazzo che acquista dimensioni imponenti
e si arricchisce di molti nuovi e bizzarri “gadgets”
che sembrano quasi anticipare le corti del Rinascimento.
E’ Galvano Fiamma, contemporaneo agli eventi, che ci informa
abbastanza ampiamente sul nuovo palazzo di Azzone[1].
Anzitutto ci rivela lo scopo politico dell’impresa:
“Dice il filosofo [Aristotele]
nel quarto libro dell’Etica che opera degna di un gran personaggio è costruirsi
una casa splendida (domum decentem);
infatti il popolo, osservando le sue mirabili dimore, resta stupito e grandemente
ammirato, come troviamo nel sesto libro della Politica. Da questo fatto deriva
la credenza che il Principe sia così potente che è impossibile attaccarlo: e la
sua magnifica residenza diventa anche una residenza conveniente per la
moltitudine dei suoi funzionari. Inoltre si richiede come azione ancora più
onorevole, ad un Principe magnifico, di costruire templi magnifici, onde
afferma il filosofo nel quarto libro dell’Etica che le spese onorevoli, che
deve fare il Principe magnifico, sono quelle in onore di Dio. E per ciò Azzone
Visconti cominciò a costruire due opere magnifiche: per prima cosa ciò che
riguarda il culto divino, cioè la mirabile cappella in onore della beata
Vergine, e quindi magnifici palazzi (pallatia
magnifica), adatti alla sua residenza.”
L’ammirazione di Galvano Fiamma per il palazzo di Azzone è
sconfinata: “Edificia ejus sive pallatia
nullos potes sufficienter exprimere”, ma lui per fortuna ci prova lo
stesso. E’ grazie a queste poche righe, sempre citate, che possiamo farci
un’idea di questo palazzo. Le riporto nella traduzione di S.
Latuada (II, pp. 127-28):
“Ordinò dunque Azzone, che in
questo palazzo vi fosse una torre, divisa in varie stanze, con sale, gallerie,
ed orti, ornati di insigni pitture. Al piè della torre, ed allo ‘ntorno furono
reperite altre stanze tutte dipinte, con istanze da riposare, riccamente
ornate, porte, ed antiporte [ne sit ad eum facilis ingressus sine speciali
licentia]. In prospetto ad una stanza vi era collocata una picciola stanza
guardata in ogni parte de’ suoi sfori con reti di bronzo, mentre serviva come
di gabbia ad ogni genere di uccelli, che ivi si conservavano. Vi era ancora il
serraglio per i quadrupedi, tra’ quali si annoveravano leoni, orsi, simie,
babbuini, e persino uno struzzo. Di rimpetto alla casa degli uccelli poc’anzi
additata vi era un magnifico salone, contradistinto col nome della Vanagloria, che ivi si vedeva dipinta,
ed all’intorno vi furono dipinti ad oro, azzurro e smalto vari principi celebri
nelle Storie, come Enea, Ettore, Ercole, Attila, Carlo Magno, ed Azzone.
Per segreti canali veniva
introdotta l’acqua, la qual sortiva incessantemente da due bocche, e si
diffondeva allo ’ntorno della quadratura del palazzo. Nel mezzo stava eretta
una colonna, in cima della quale si vedeva una statoa rappresentante un
angiolo, che teneva una bandiera colla Vipera, stemma della Famiglia Visconti;
sotto di cui vi avevano quattro capi di leoni, da’ quali sortiva acqua, che
formando uno stagno, serviva di recipiente per varj generi di pesci. Da una
parte dello stagno fu disposto un bellissimo claustro con navi e figure, che
rappresentavano la Guerra di Cartagine: dall’altra parte un ameno Giardino, in
cui si conservavano uccelli acquatili e marini, dapprima non veduti in questa
città. Oltre a tutto ciò erano le pareti mirabilmente dipinte, e formavano
molte comode stanze. A canto al Giardino si alzava il Palazzo, con le Camere
inferiori, e le superiori servivano d’albergo alla famiglia.”
Ipotesi interpretativa del
palazzo
Nessuno finora ha provato a decodificare questa descrizione,
collocandola nella pianta che si può ricostruire di questo antico palazzo.
Cos’ha fatto dunque Azzone? Sappiamo, sempre dal Fiamma, che Azzone compera le
case di alcune famiglie, crea una grande piazza e costruisce alcuni edifici in
modo da formare un grande quadrato. Questo quadrato è riportato nella pianta di
Milano disegnata dal Fiamma dove è anche segnata la sua dimensione: 10
pertiche, corrispondenti a 6.545 mq. Un quadrato quindi di circa 80 m di lato,
che corrisponde abbastanza bene all’antico cortile d’onore del palazzo, di cui
oggi resta integro solo un lato, l’attuale facciata del Piermarini, che misura
76 metri. Di questo quadrato, per intenderci, chiameremo in questo modo i
quattro lati:
 |
lato est verso l’Arcivescovado: manica corta |
 |
lato sud (facciata del Piermarini): corpo tra il cortile e il giardino |
 |
lato ovest verso l’Arengario: manica lunga |
 |
lato nord (demolito): fronte
sulla piazza |
La manica corta e i corpi che si affacciano sul cortiletto
che si trova entrando dal n. 14 di piazza del Duomo erano probabilmente le parti già esistenti
risistemate da Matteo. Ne farebbero fede i quattro arconi gotici che si vedono
ancora entrando nel cortile e che sembrano risalire a quell’epoca.
Il lato
della facciata del Piermarini (in corrispondenza della seconda e terza finestra)
ingloba un’antica torre ben visibile nelle vedute antiche del cortile che forse
è anch’essa parte dell’antico palazzo di Matteo. Addossati alla parete
orientale della torre (visibili nella sala del Museo del Duomo dove c’è il
grande modello ligneo) ci sono due arconi gotici che sembrano ancora più
antichi di quelli di Matteo per la quota più bassa e perché duplicano il muro
della torre.
Dalla torre all’angolo ovest della facciata e lungo tutta la
manica lunga correva un ampio portico costruito secondo un modulo unico di 10
braccia x 15 braccia (circa 6 x 9 metri) con 14 archi sulla manica lunga e 10
sul lato della torre dove il porticato si interrompe. Per l’unitarietà e la
regolarità del lavoro questi due corpi di fabbrica dovrebbero essere senz’altro
quelli di Azzone.
Il corpo verso il giardino retrostante era un semplice
porticato sopra il quale si disponevano le camere. L’altro corpo, verso via
Rastrelli, era doppio con una serie di camere al piano terreno lungo il portico
e sopra forse un unico grande salone.
Il lato verso la piazza, demolito dal
Piermarini, era in realtà già stato più volte manomesso per consentire
l’avanzamento del Duomo.
Le più antiche piante e vedute rimasteci ci fanno
vedere i molti rappezzi e l’unico lato ancora antico verso ovest, dov’era
conservata una torre a tre piani con un grande finestrone gotico. Attaccato
alla torre c’era un edificio su tre piani molto più basso dei due piani (piano
nobile e mezzanino) presenti sugli altri tre lati del quadrato. E’ possibile
che Azzone abbia costruito questo lato servendosi largamente di edifici
(compresa la torre) preesistenti, allineati lungo un’antica strada che
proseguiva dopo la via Cappellari.
All’estremità di questo lato, che veniva
quasi a toccare la facciata di S. Maria Maggiore, c’era infine un’altra torre
che era servita da campanile della cattedrale dopo le distruzioni del
Barbarossa e che chiudeva il quadrato addossandosi al vecchio palazzo del
broletto. Non si sa nulla invece della quarta torre che secondo il Fiamma era
presente lungo il perimetro del grande quadrato.
Tornando alla descrizione sopra citata, possiamo azzardare
qualche ipotesi. La torre citata con intorno le stanze dipinte potrebbe essere
quella di Matteo sul lato verso il giardino. Le porte e antiporte si trovavano
sul lato verso la piazza (al centro), sulla manica corta (verso l’antica piazza
del Broletto c’erano forse due o tre porte), ed una verso il giardino, a fianco
della torre, che portava alla chiesa di S. Gottardo. La Stanza degli uccelli e
il Serraglio erano certamente sull’area del giardino, tra il palazzo e la
chiesa. La persistenza di finestre gotiche verso via Rastrelli ci dice che
esisteva un corpo sporgente dal quadrato che si allungava per un breve tratto
verso sud. Il magnifico salone con la Vanagloria,
posto accanto alla Casa degli Uccelli, doveva essere quello sopra il portico
meridionale dove nel Cinquecento verrà collocato il Senato. Torneremo in
seguito sulla Vanagloria e sulla
discussione se fosse o no un affresco di Giotto.
Il seguito della descrizione, che dovrebbe essere di un
testimone oculare, presenta aspetti strani, per non dire favolosi. Il fossato,
la fontana, lo stagno, il chiostro, il giardino furono realmente costruiti o si
tratta di un progetto discusso ma non realizzato? Il fossato difficilmente
poteva circondare un quadrato che presentava sporgenze verso sud-est e verso
sud-ovest. Non c’è traccia di questo fosso né di ponti in alcun documento. Per
quanto riguarda la fontana con il suo stagno-peschiera, chiostro e giardino, il
Fiamma la colloca al centro del quadrato, ma tutti in seguito pensarono - più
giustamente - che questo luogo di delizie avrebbe dovuto essere piuttosto nello
spazio retrostante al palazzo verso la chiesa di S. Gottardo, da un lato, e la
chiesa di S. Andrea al Muro Rotto, dall’altro lato. In questo caso il chiostro
con la Guerra di Cartagine sarebbe
sorto lungo la via Rastrelli.
Torniamo ora sia pure brevemente alle pitture. Tra il 1335 e
il 1336, nel periodo in cui fervevano i lavori del palazzo, sappiamo dal Vasari
che Giotto soggiornò a Milano, inviato dai Fiorentini per aiutare Azzone nella
sua impresa. Nei Commentari del
Ghiberti si dice che Giotto ha dipinto “di sua mano una Gloria Mondana” in un
luogo che non viene precisato. Componendo queste due informazioni con la
citazione della Vanagloria di Galvano
Fiamma, si è dedotto che questo affresco fosse stato dipinto da Giotto, che,
come sappiamo, venne a Milano con molti aiuti che lasciarono un segno profondo
nella pittura lombarda del Trecento. Uno studio recente di Creighton Gilbert
(vedi Bibliografia) individua la possibilità di una derivazione da questo
affresco di Giotto della miniatura riportata in più manoscritti del De Viris illustribus del Petrarca
risalenti alla seconda metà del Trecento. Si vede la Gloria alata su un carro
dentro una mandorla e sotto di lei un folto gruppo di cavalieri che la
invocano, alcuni dei quali portano la corona.
La chiesa di San Gottardo in Corte
La chiesa di S.
Gottardo sul lato opposto dell’isolato, verso la contrada delle Ore, presenta
meno problemi di interpretazione anche perché nel tempo ha subito meno
trasformazioni e modifiche del palazzo. Il Fiamma dice che era racchiusa tra
alte mura, aveva tre campate e mirabili pitture. Nella cappella maggiore
c’erano cortine fatte di metallo e gemme, storie della Beata Vergine, mirabili
finestre (o vetrate?). Due pulpiti rivestiti d’avorio e molti altari con
ornamenti auroserici. Poi accenna agli arredi sacri e alle reliquie, tra cui
una piccola croce che, esposta alla pioggia e alle tempeste, scacciava ogni
pestilenza. Gli arredi depositati nella sacrestia valevano più di 20.000
fiorini. Pari attenzione è dedicata ovviamente al campanile che ancora oggi
possiamo ammirare quasi intatto: ne viene descritta la forma, l’angelo
metallico che lo sovrasta, le campane e
“... l’orologio mirabile, perché
ha un batacchio molto grosso, che percuote una campana per 24 volte, secondo il
numero delle 24 ore del giorno e della notte, in modo che alla prima ora della
notte dà un tono, nella seconda due colpi, nella terza tre e nella quarta
quattro, e così distingue le ore le une dalle altre; il che è indispensabile
per ogni ceto di uomini.”
Sappiamo tutti che questo orologio, forse il primo che
compare a Milano[2],
fece molto scalpore in città mutando anche il nome della via in contrada delle
Ore. E’ interessante osservare anche come erano computate le ore: all’italiana
o alla babilonica, cioè in un unico ciclo di 24 ore a partire dal tramonto,
anziché in due cicli di 12 ore a partire da mezzogiorno come avveniva nel resto
d’Europa. Sulla chiesa, a chiarire ulteriormente la sua storia, c’era inoltre
una lapide con la seguente iscrizione:
ALMA
VIRGO POLI DEVOTUM SVSCIPE TEMPLUM
QVOD
VICECOMES AZO PROLES GENEROSA PARENTUM
CONSTRVI
MANDAVIT NATO DE SEMINE DAVID
ET
VBI RECTA VIA FIANT LIBAMINA PIA.
PRINCEPS
ANGELORUM VOCANTEM RESPICE CHORUM
VOS
AMBO IOANNES PRECVRSOR ET ZEBEDEVS
HUNC
PROTEGATIS NE SIT PRO CRIMINE REVS
INCLITE
GEORGI AZONEM RETINE CORDI:
EVSTACHI
CHRISTI MILES SVBVENIES ISTI
VT
CVSTOS VERI VALEAT SVA IVRA TVERI.
ANNIS MILLENIS TERCENTIS TERQUE DENIS
SEX
SECUM ADIVNCTIS FINITVR ECCLESIA FONTIS.
La chiesa, terminata nel 1336, è chiamata “del fonte” forse
perché sostituisce il battistero di S. Giovanni in Fonte abbattuto da Azzone per
allargare la piazza. E’ dedicata alla Vergine, a S. Michele arcangelo, ai SS.
Giovanni Battista ed Evangelista, a S. Zebedeo, ai SS. Giorgio ed Eustachio
(protettori di Azzone). Non si parla nella lapide di S. Gottardo, eppure prima
il Fiamma e poi il Corio dicono che la chiesa (o un suo altare?) era dedicata a
S. Gottardo perché Azzone soffriva di gotta e quello era il santo giusto a cui
votarsi per combattere quella malattia.
Un’altra piccola lapide sul campanile dice “Magister Franciscus de Pecoraris de Cremona
fecit hoc opus”; grazie ad essa sappiamo che l’elegante campanile venne
realizzato da Francesco Pecorari di Cremona. Mentre il campanile è rimasto
miracolosamente intatto, la chiesa ha subito alcune trasformazioni all’esterno
ed un totale rifacimento neoclassico all’interno. La facciata originaria, come
si può vedere da una stampa settecentesca riportata dal Giulini, era molto
semplice: un portale con sopra un’edicoletta con una statua, un rosoncino e una
bifora. Il portale (senza la statua) e il rosone sono ora visibili sul fianco
meridionale della chiesa. Resta poco esplorata l’origine di questa chiesa o
almeno di quella parte che forma la cappella maggiore. La sua struttura
ottagonale e il coronamento romanico fanno certamente pensare ad un edificio
preesistente sul quale è stata innestata la navata. Le finestre gotiche
attuali, rifatte alla fine del secolo scorso, hanno cancellato le tracce delle
finestre precedenti, rettangolari, che erano probabilmente anche loro
rifacimenti successivi. Cos’era questo edificio? In quella zona c’erano almeno
altre tre costruzioni rotonde o poligonali: l’attuale Rotonda del Pellegrini,
la Penitenzieria e le Scuole Canobbiane. Tutti resti di un sistema difensivo a
protezione dell’arcivescovo o del Broletto Vecchio? Ulteriori studi forse ce lo
diranno. All’interno è scomparsa ogni traccia delle pitture e degli addobbi
trecenteschi. Rimane però un affresco, conservato oggi dentro la chiesa, a
testimoniare il livello di quelle pitture. Come vedremo al termine di questo
scritto, è stato ritrovato in questo secolo ed è stato oggetto di lunghe
discussioni da parte degli storici dell’arte. Si trovava su una parete alla
base del campanile dove forse c’era una cappella. Intorno alla chiesa, infatti,
c’erano molti locali che formavano un piccolo convento affidato da Azzone ai
Francescani. Ne accenna anche il solito Fiamma che parla di un chiostro
quadrato con lavatorio di bronzo, refettorio e diverse officine. Sopra erano
sistemate le celle e i corridoi decorati con buone pitture.
Una piccola nota di colore: il 29 marzo 1336, Giovanni
Visconti, zio di Azzone, assolve il nipote dalla scomunica ricevuta dal papa
per aver costruito la chiesa di S. Gottardo senza le necessarie autorizzazioni
ecclesiastiche. Ogni epoca ha i suoi condoni edilizi.
L’epoca viscontea
I lavori eseguiti da Azzone, che tanto entusiasmarono
Galvano Fiamma, non devono aver riscosso eguale consenso da parte della
famiglia. Alla morte di Azzone, in mancanza di eredi diretti, il potere passa
agli zii Giovanni e Luchino. L’arcivescovo Giovanni resta ad abitare nelle sue
case del Verziere (in piazza Fontana dov’è la tristemente celebre Banca
dell’Agricoltura) e amministra il suo mandato nel palazzo che si era appena
costruito (l’attuale Arcivescovado). Luchino invece si fa costruire un nuovo
palazzo accanto a quello di Azzone, forse perché quel palazzo non gli piaceva o
più probabilmente per fortificare meglio gli isolati situati tra il palazzo e
l’attuale via Unione, che i Visconti consideravano ormai come un loro possesso.
Dal 1339 al 1354, quando, dopo Luchino, muore anche Giovanni, il palazzo sembra
essere quasi abbandonato. Solo la chiesa conserva la sua importanza e riceve i
costosi monumenti funebri di Azzone e di Luchino, sostituendo quindi S.
Eustorgio come cappella ufficiale della famiglia Visconti.
Quando salgono al potere i tre nipoti, Matteo II, Galeazzo
II e Bernabò, questi si spartiscono le tre residenze alloggiando
rispettivamente nei palazzi di Giovanni, di Azzone e di Luchino. Matteo muore
dopo un anno lasciando la sua residenza a Galeazzo che ne fa una dipendenza del
suo palazzo. Siamo nel 1355, Galeazzo possiede dunque un grande complesso
edilizio con saloni decorati, giardino, chiostri, saloni. Cosa se ne fa? Secondo il cronista Pietro Azario, che finì
di scrivere il suo Liber Gestorum in
Lombardia nel 1362, Galeazzo distrusse le costruzioni di Azzone, tranne la
chiesa e la torre, “cum ornamentis et
picturis et fontibus” per edificare un nuovo palazzo. In sostanza, dice
l’Azario, distrusse un patrimonio che valeva più di 300.000 fiorini. Forse
l’Azario, che non aveva molta simpatia per i Visconti, esagera un po’. Non si
capisce perché Galeazzo avrebbe dovuto sprecare tanti soldi se si pensa che
stava costruendo (dal 1358) il Castello di Porta Giovia e che dal 1360
comincerà gli imponenti lavori del Castello di Pavia. Comunque è difficile
pensare che il grande portico sia stato rifatto da lui, se non altro perché è
molto più arcaico e rozzo di quello di Pavia, che ha eleganti colonne e
capitelli di pietra. E’ più probabile che Galeazzo abbia fatto abbattere le
costruzioni che si trovavano tra il cortile grande e la chiesa - fontana,
serraglio, chiostro con le Guerre puniche - dato che ormai disponeva di due
enormi parchi dietro i suoi due castelli dove trasferire pesci, uccelli e gli
altri animali esotici. Al posto di queste amenità avrà forse rinforzato il lato
verso via Rastrelli confinante con la corte del temuto fratello Bernabò e
difatti alcuni (ad esempio, Dell’Acqua) attribuiscono proprio ai lavori di
Galeazzo i finestroni gotici riapparsi su questo lato del palazzo. Comunque, in
attesa della conclusione dei lavori di Pavia, Galeazzo, con la sua famiglia e
la corte, rimane nel palazzo di Azzone fino al 1365 quando la gotta lo colpisce
gravemente costringendo tutti a precipitarsi nel castello pavese, non ancora
ultimato, per paura che Bernabò cogliesse questo momento di debolezza per
annientarli.
Il palazzo resta nuovamente vuoto. Gian Galeazzo lo usa come
un (enorme) pied-à-terre e lo
utilizza, ad esempio, per il grande pranzo e i tornei organizzati in occasione
dell’incoronazione a duca nel maggio 1395. Nella storia del Corio (pp. 267-68)
viene ampiamente descritta questa festa sontuosa che si svolse nell’ “antica corte nominata l’Arenga, nel capo
della quale gli era posto una ampla, et ingente mensa, coperta con un Cielo di
drappi contesti di lucidissimo oro...” Segue la descrizione delle tavole,
l’infinito menù di carne e pesce, i regali agli ospiti, i tornei che si
protrassero da lunedì a giovedì, sempre nel grande cortile dell’Arengo. Da
allora il palazzo prenderà il nome di “Corte ducale”. Nello stesso periodo,
Gian Galeazzo concesse agevolmente che si distruggesse una parte del palazzo
per far posto ai lavori del Duomo. Molto probabilmente venne sacrificata una
parte del Broletto Vecchio che correva accanto all’antica Domus Ambrosii, anch’essa contestualmente distrutta. Alla morte di
Gian Galeazzo, il figlio Giovanni Maria riapre i saloni della vecchia corte ed
è proprio qui, davanti o dentro la chiesa di S. Gottardo, che viene
assassinato. Questa sciagura colpì duramente il superstizioso fratello Filippo
Maria che non volle mai utilizzare questa corte come residenza. Vi confina
invece (sperando che morisse?) Maria di Savoia, la donna che gli avevano fatto
sposare per forza e che lui non voleva nemmeno vedere per paura che gli
imputassero un eventuale erede. L’abbandono doveva essere quasi totale se nel
1443 crollò addirittura il grande salone a destra di chi entrava dove abbiamo
supposto ci fosse l’affresco di Giotto della Vanagloria.
La Repubblica Ambrosiana e gli Sforza
La morte senza eredi diretti di Filippo Maria Visconti il 13
agosto 1447 provoca un terremoto politico a Milano. Il giorno seguente alcuni
nobili convocano il popolo nell’Arengo, cioè nel cortile della Corte ducale da
più di un secolo ormai sbarrato al popolo da porte e antiporte. Qui viene
proclamata la Repubblica Ambrosiana e qui si installa il nuovo governo che fa
distruggere il Castello di Porta Giovia. Si torna quindi simbolicamente al
“Broletto Vecchio” mentre anche il Carroccio viene ricostruito e collocato
accanto al Duomo. Il palazzo viene restaurato utilizzando anche il serizzo
prelevato dal Castello. Non viene utilizzata invece la chiesa di S. Gottardo,
anzi, i suoi prezioni arredi sacri sono donati al Duomo, che di tutto quel
grande tesoro (vedi l’inventario riportato in Corio, cit., p. 212) conserva
oggi solo un calice gotico e forse alcune figure in rame sbalzato.
E’ forse per dimostrare il suo animo “repubblicano” che
Francesco Sforza, conquistata Milano nel 1450, va a stabilirsi nello stesso
palazzo? Certo all’inizio lo Sforza si dimostrò molto prudente sia nei
confronti della città (stabilendosi nel glorioso Broletto Vecchio) sia nei
confronti di se stesso (iniziando a ricostruire il Castello); inoltre diede
subito l’assenso per l’abbattimento dell’angolo nord-orientale del grande
cortile in modo da consentire il proseguimento delle navate. Ci fu in realtà a
questo proposito qualche dissapore con la Fabbrica che aveva previsto fin
dall’inizio la lunghezza del Duomo in otto campate mentre il nuovo duca voleva
che ci si fermasse alla sesta. Si giunse a un compromesso: l’angolo del palazzo
fu demolito in modo da consentire i lavori fino alla sesta ma sulla piazza fu
posto un segno per indicare il termine all’ottava. Ci vorrà un altro grande
diplomatico - Federico Borromeo - per risolvere questa vertenza 150 anni più
tardi!
Le notizie sui lavori di sistemazione del palazzo eseguiti
nella seconda metà del Quattrocento sono piuttosto scarse e frammentarie. Il
Filarete nel suo Trattato (libro I,
29, f. 5v) cita la corte come esempio di edificio “ammalato” e “mezzo morto”
che Francesco Sforza avrebbe risanato. Sappiamo che il Filelfo aveva composto
nel 1455-56 otto epigrammi da dipingere sotto altrettante figure previste nel
cortile -Nino, Semiramide, Ciro, Tamiri, Alessandro Magno, Mirina, Giulio
Cesare, Pentesilea - forse un’eco della Vanagloria
ormai scomparsa. La stessa idea e quasi gli stessi personaggi compaiono anche
nei Palazzi del Signore del Filarete a Sforzinda e a Plusiapolis. Il numero
otto fa pensare che queste figure fossero affrescate tra le finestre del piano
nobile sul corpo verso il giardino dove ci sono appunto otto spazi regolari tra
l’angolo meridionale e l’antica torre. Negli stessi anni Bartolomeo Gadio
relaziona la duchessa Bianca Maria sui rifacimenti della camere. Questi lavori,
compresi i numerosi affreschi realizzati nelle camere e nel portico, saranno nel
1460 addebitati in parte alla Fabbrica del Duomo in cambio della porzione di
palazzo ceduta e demolita. Di tutto ciò resta ben poco: la foto di alcuni
affreschi ritrovati nella Manica lunga durante la sua demolizione nel 1936.
Nel 1463, poco prima della morte del duca e del
trasferimento della corte nel Castello, il palazzo aveva ritrovato un momento
di splendore. Dal libretto delle spese di corte scoperto nell’Ottocento dallo
storico Marco Formentini, sappiamo che vi risiedevano circa 120 camerieri, 54 servi
(schiavi?), 69 ragazzi, 8 cocchieri, 25 stallieri, 6 cuochi, 2 sguatteri, un
certo numero di apparecchiatori delle tavole, 1 cantiniere e i mulattiere.
C’erano poi il sescalco, fornai, barbieri, sarti e calzolai, 18 persone con
ufficio di maggiordomo, 22 falconieri, 3 addetti agli sparvieri, alcuni
credenzieri, 2 medici, 1 speziale, 1 cappellano, cantori e musici, addetti alla
cancelleria. Il personale della duchessa contava 4 dame e 16 damigelle.
Galeazzo Maria, che aveva allora 19 anni, teneva “una propria casa con cucina
in una parte separata del palazzo”, dove vivevano anche i suoi figli
illegittimi, nati dalla relazione con Lucrezia Landriani. C’erano poi 45
persone addette ai principini. La spesa giornaliera per la mensa della famiglia
ducale era di lire 30, soldi 17 e denari 4, pari secondo la Santoro a 150.000
lire del 1968 (circa 3 milioni di oggi).
Lo splendore durò poco. Nel 1469, subito dopo il matrimonio
di Galeazzo Maria e la morte di Bianca Maria, la corte si trasferì nel Castello
e della vecchia Corte non se ne sentì più parlare per quasi cinquant’anni,
durante i quali probabilmente il vecchio edificio cadde di nuovo ammalato.
Ultimo aggiornamento: lunedì 29 luglio 2002
paolo.colussi@rcm.inet.it
|
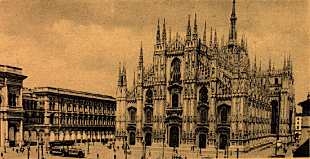 Atlante
milanese
Atlante
milanese