| Home | La città | Personaggi | Arte | Miti e leggende | Repertori | Cronologia | Links utili |
|
||||||
|
Le “imprese” Visconti-Sforzadi Franca GuerreriLa storia di una famiglia regnante vista attraverso gli stemmi
personali dei suoi membri a cura di Adriano Bernareggi Capitolo II
“Mit Zeit”“Mit Zeit”, col tempo; “Ich hof”, io spero; “Merito et tempore”…, oggi si direbbe “il tempo è galantuomo”. Nell’elaborare un progetto di regno italico, unici in questo tra le famiglie potenti della loro epoca, i Visconti-Sforza s’appellarono alla “giustizia” del tempo, giustizia che come vedremo non venne loro riconosciuta. Fu un cammino, il loro, tormentato dall’ansia di legittimazione da parte dell’autorità imperiale e dal desiderio di apparire ai sudditi delle terre conquistate come inviati dalla Provvidenza per compiere dei disegni divini. I risultati furono effimeri. Le loro imprese araldiche rappresentano delle vere tappe che esprimono di volta in volta le speranze di ritorno dall’esilio, il riscatto da un passato umiliante, l’orgoglio per aver costituito un regno a carattere ereditario in cui esisteranno solo pace e prosperità. Sullo scenario drammatico di una Milano in piena crisi comunale, le famiglie Torriani e Visconti si affrontano per ottenere il controllo della città. La via Case Rotte ricorda ancor oggi uno dei tanti episodi violenti di questa guerra che vede in un primo tempo i Torriani affermarsi in qualità di Anziani o Podestà perpetui del popolo. Dovremo aspettare il 21 gennaio 1277 per vedere, dopo la battaglia di Desio, questi ultimi in ginocchio, battuti dall’arcivescovo Ottone Visconti. In ginocchio è infatti raffigurato, nel ciclo di affreschi che commemorano il fatto nella rocca di Angera, Napo Torriani mentre chiede pietà per sé e per la sua gente al grande nemico che, nominato arcivescovo di Milano nel 1262 dal papa Urbano IV, proprio a causa dell’ostilità dei Torriani aveva dovuto aspettare quindici anni per occupare la propria sede. Signore in sordina Ottone, Signore pubblicamente
riconosciuto il nipote Matteo che lo sostituì nel governo della città.
Fu grazie all’esborso di 75.000 fiorini oro versati a spese della comunità che
nel 1311 Matteo venne nominato dal “grande Arrigo”,
l’imperatore di dantesca memoria, Vicario imperiale. L’aquila nera dalle ali
patenti, simbolo dell’impero, proteggerà d’ora in poi il biscione, “la vipera ch’el Milanese accampa”, come dice Dante nel Purgatorio. Da
insegna militare il biscione è diventato stemma di famiglia. Secondo la
leggenda ricordata anche dal Tasso (“Gerusalemme liberata”, canto I), questa
vipera o biscione era raffigurata sullo scudo di un feroce saraceno, vinto e
ucciso durante la prima crociata da un “forte Otton”, omonimo antenato
dell’arcivescovo. Portato in terra lombarda, fece la sua prima apparizione a
Legnano, sulla facciata di un palazzo proprietà dei Visconti. Lo scultore Lombardi, nel realizzare una delle porte del
duomo di Milano, dà credito a questa leggenda e raffigura l’episodio del
saraceno ucciso mentre imbraccia lo scudo “su cui dall’angue esce un fanciullo
ignudo” (“Gerusalemme…” ibidem).
Tavola 1 - “Il forte Otton che conquistò lo scudo su cui dall’angue esce il fanciullo ignudo” (Tasso) abbatte il saraceno cui toglierà l’impresa, mentre Giovanni da Rho entra in Gerusalemme (Milano, Duomo, porta Lombardi) Tavola 2 - Il Biscione La “parlera” (balcone) da cui venivano annunciate, fra l’altro, le condanne a morte. Le immagini simmetriche del biscione inquadrano l’Aquila della giustizia. La chiusura a cerchio della seconda spira indica che ci troviamo in presenza del ramo principale della casata. Una versione moderna del Biscione, col motto di Galeazzo II, “Ic[h] hof”, “Io spero”. Castello sforzesco, torre “del Filarete” (in realtà del Beltrami, 1905) Sinistra: il Biscione inquartato coll’Aquila dopo il conferimento del vicariato imperiale a Matteo Visconti. Destra: Biscione, Aquila e Gigli di Francia per il matrimonio di Galeazzo Maria Sforza con Bona di Savoia. Il Biscione utilizzato in due noti marchi commerciali. In quello di Canale 5 l’uomo nelle fauci del rettile si è trasformato in un più rassicurante fiore. La vera impresa di Matteo non consiste tanto nell’aver ottenuto che
l’aquila imperiale si inquartasse col biscione,
quanto nell’aver commissionato ad un pittore rimasto per noi ignoto il ciclo
pittorico della rocca di Angera, un tempo proprietà della diocesi ambrosiana
ma incamerata dall’arcivescovo tra i beni della famiglia, non senza l’autorità
di un documento redatto appositamente per dimostrarne l’antica appartenenza
viscontea. Quanto meno limpide sono le origini di un
potere politico, tanto più sono necessarie giustificazioni dedotte dal corso
del destino. La propaganda viscontea, che aveva già individuato ai tempi della
prima crociata la missione dei Visconti come vincitori delle forze del male,
ora li vede in questo ciclo restauratori dell’ordine
cosmico. Nella sala della Giustizia della rocca (e la scelta della sala non è
certo casuale) Matteo scomoda addirittura la Provvidenza, raffigurata mentre aziona la ruota della Fortuna, affinchè
in armonia coi cicli cosmici, il 21 gennaio 1277, avvenisse la disfatta dei
Torriani. In realtà di provvidenziale in questa battaglia ci fu solo la
soffiata di un traditore che permise di sorprendere i nemici nel sonno, dando
luogo ad un eccidio notturno. Non sarà un problema per Ottone, incontrastato
vincitore, risparmiare per il momento Napo Torriani. La Fortuna, sempre al
servizio della Provvidenza, farà sì che il Visconti si
“dimentichi” di lui nella gabbia appesa davanti al Palazzo Pubblico, sinchè
fame, intemperie e uccelli rapaci compiranno la loro giustizia. Tavola 3 - Angera Rafforzò Matteo il suo potere non solo territorialmente, creando una cintura di città satelliti controllate dai figli attorno
a Milano (Alessandria, Novara, Monza, Bergamo, Como, Piacenza e Tortona), ma lo
temprò soprattutto nella lotta con Giovanni XXII. Il Papa non tollerava nella prestigiosa sede di Milano un Vicario imperiale che
limitasse la sua influenza. Dalla sede di Avignone
lanciò delle terribili accuse contro Matteo ed i suoi figli: eretici, detentori
di libri magici, vessatori della Chiesa (avevano confiscato i beni
ecclesiastici ritenuti improduttivi), di condotta impudica (i giovani Visconti
andavano dicendo in giro che giacere con donne non è peccato). Da Signore desideroso di verificare la solidità del suo operato, Matteo
abdicò a favore del più anziano dei suoi figli, Galeazzo, sposo di Beatrice
d’Este, vedova di quel Nino “gentil” giudice di Gallura, che in Purgatorio si
era lamentato con Dante della volubilità dell’animo femminile. Vedova non
proprio inconsolabile, Beatrice era convolata a nuove nozze col Visconti prima
che fosse trascorso il periodo di lutto. Il frutto
della nuova unione era stato Azzone, succeduto al padre nel 1329. L’impegno
politico di Azzone fu quello di vanificare le restanti
libertà comunali e non solo per i Milanesi. Lo fece in modo non traumatico, da
quel Signore raffinato che era, e lo giustificò col successo delle sue azioni,
decise “colà dove si puote ciò che si vuole”. Fu infatti
l’intervento miracoloso di sant’Ambrogio a volgere a favore di Azzone la
battaglia di Parabiago contro il rivale cugino Lodrisio: l’evento straordinario
è ricordato nella cappella Grifi di San Pietro in Gessate, nella Crotta-Caimi
in S. Eustorgio e in una formella della porta del Castiglioni sulla facciata
del Duomo. Tavola 4 - S.
Ambrogio interviene miracolosamente a sostegno di Azzone
Visconti nella battaglia di Parabiago: a
sinistra nella porta Castiglioni del Duomo, a destra nel dipinto di G. A. Figino in S.
Eustorgio. Lo giustificò ancora con l’apparato iconografico del proprio monumento
funebre ancor oggi visibile, seppur mutilo, nella chiesa che Azzone volle dedicata a san Gottardo, protettore dei gottosi,
perché gli lenisse i tormenti del male. Sul sarcofago, confortate dai
rispettivi santi protettori, piangono assieme alla vedova Caterina di Savoja,
le città assoggettate al potere visconteo. Piangono un tiranno liberticida? No,
piangono chi aveva garantito loro sicurezza e pace, e proprio per questo aveva ottenuto dall’imperatore Venceslao, presente fra i
dolenti, il rinnovo del Vicariato imperiale. Tavola 5 - Presentate dai rispettivi santi protettori, le città soggette rendono omaggio al Signore di Milano. (Milano, chiesa di S. Gottardo al Palazzo, monumento funebre ad Azzone Visconti) Non dovettero dispiacersi più di tanto i Milanesi per le libertà
perdute, impegnati com’erano a trarre profitto dai commerci, particolarmente
fiorenti grazie alla sicurezza che le milizie mercenarie, impiegate per la
prima volta in modo sistematico da Azzone, garantivano. Senza dubbio furono
anche gratificati d una Milano che si faceva bella, pervasa com’era da un
soffio di gusto toscano: Giovanni di Balduccio aveva
ingentilito con Madonne e santi protettori le porte cittadine, aveva
eretto in Sant’Eustorgio un’arca a Pietro Martire, opera senza eguali per
eleganza e spiritualità. Nel 1339, alla morte di Azzone, dei cinque figli di Matteo (Galeazzo, Marco,
Luchino, Stefano, Giovanni) erano rimasto solo Luchino e l’arcivescovo
Giovanni. Prode soldato il primo, porta impressi sul corpo i segni di animose battaglie; il secondo dissimula interessi
politici con la cura di studi umanistici nella sua sede dell’Incoronata.
Luchino mira ad una conservazione personale del potere. La congiura dei
Pusterla, vera o presunta, gli dà modo di sbarazzarsi di una famiglia nobile,
potente e pericolosa. Si dice che i congiurati
facessero sotto tortura i nomi dei suoi stessi nipoti, Galeazzo, Matteo e
Bernabò, i figli di Stefano Visconti e Valentina Doria. Fu un buon motivo per
levarseli di torno, condannandoli all’esilio. L’orgoglio ferito di Galeazzo,
esule in terra di Francia, lo spingerà a creare la sospirosa impresa del leone
galeato con motto di speranza sul proprio ritorno in patria, cosa che avvenne
alla morte di Luchino. Tornato e riacquistata la propria
dignità di Signore, Galeazzo condivise il governo di Milano col fratello
Bernabò. Sparì presto dalla scena e al figlio Giangaleazzo, enigmatico
adolescente, lasciò campo libero perché dispiegasse tutta la sua abilità
politica. Con Giangaleazzo la politica viscontea toccò il vertice del successo e,
nello stesso tempo, mostrò tutta la sua fragilità. Le imprese di questo Visconti rappresentano la coerente espressione dei
suoi progetti e delle tappe percorse per realizzarli, sottolineandone sempre
l’ispirazione divina. Ottenne il titolo ducale, la morte
improvvisa gli impedì di consacrare un regno già territorialmente
conquistato. Delle sue ambizioni rimasero una cattedrale, quella che aveva
legato in voto per la nascita di un erede tardo a venire, una cappella
funeraria degna di un re, un testamento che tormentò gli eredi. Dei quali eredi il cielo, tanto invocato a
giustificazione di una politica aggressiva, si compiacque poco: il primogenito
fu eliminato da una congiura; il secondogenito, divenuto terzo duca, dovette
destreggiarsi fra l’espansionismo dei Veneziani, l’arroganza dei capitani di
ventura ormai veri arbitri della situazione, e la mancanza di un erede maschio.
Fu proprio con uno di questi capitani, il saggio e maturo
Francesco Sforza, che pensò di risolvere i problemi di continuità dinastica e
stabilità del ducato, dandogli in moglie Bianca Maria, figlia naturale ma
legittimata. Valse a poco la propaganda raffinata messa in atto da Filippo
Maria per rassicurare i sudditi sulle capacità politiche del suo successore e
sulla legittimità della propria discendenza: alla morte del duca Francesco e
Bianca Maria si trovarono a dover rifondare una stato
che di solido non aveva altro se non il loro legame coniugale. La chiesa di san
Sigismondo a Cremona, in cui fu celebrato il matrimonio il 25 ottobre 1441,
assunse un significato particolare. Fu trasformata in un tempio votivo a gloria
del nuovo stato, dell’aspirante duca e della sua futura prole. Le nozze di
Francesco e Bianca Maria sono immortalate nell pala di Giulio Campi, posta
sull’alter maggiore: a proteggerle, in quanto atto di fondazione di un nuovo stato,
sono presenti i santi venerati il 25 ottobre dal calendario romano, Sigismondo,
Gerolamo, Crisante, Daria; ad approvarle e quindi a legittimarle appare la Vergine in una gloria di angeli. La sorte volle che il tanto contestato Francesco
e la sua discendenza fossero riconosciuti legittimi dalle dominazioni
straniere: tanto il re di Francia Luigi XII quanto
l’imperatore Carlo V e il suo successore Filippo II non si sottrassero al
rispetto dei tanti benefici concessi da Bianca Maria alla chiesa di san Sigismondo,
il cui ricordo permane nell’unica impresa raffigurante un forziere con mano
divina radiata che porge la chiave, visibile ancor oggi in uno stallo del coro. Il problema della legittimità del potere non angosciò il figlio di
Francesco, succeduto al padre e noto fra i
contemporanei come “testa bucata”, tutto preso com’era a godere dei vantaggi
della sua posizione. Preoccupò invece, e parecchio, Ludovico il Moro, reggente
in nome del giovanissimo nipote, figlio del defunto Galeazzo Maria. Intravide
la possibilità di un regno tutto per sé, sia pur al prezzo di dover
attraversare mari procellosi, come indica una sua
raffinata impresa. I tempi non gli furono favorevoli: l’impresa
dell’arcobaleno, propria del fratello Ascanio a lui vicino in tragiche circostanze,
gli profetizzò un regno sereno non certo su questa terra. Vai al Capitolo III >>> Ultima modifica: martedì 1 febbraio 2011 adriano_1943@libero.it |
||||||






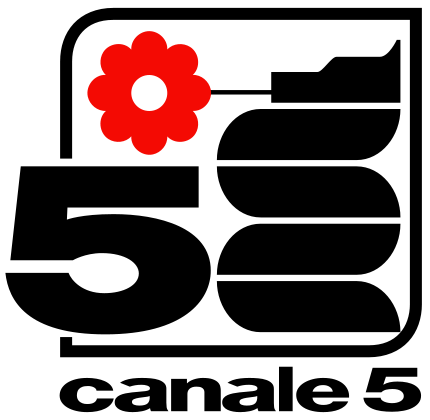

 Rocca di Angera, sala della Giustizia. Il Biscione, ormai divenuto stemma di famiglia, suggella i fasti di casa Visconti raffigurati sulle pareti. Tra questi, fondamentale la vittoria di Desio sui Torriani, qui ricordata con l’immagine dello sconfitto Napo che implora pietà per sé e per la sua parte.
Rocca di Angera, sala della Giustizia. Il Biscione, ormai divenuto stemma di famiglia, suggella i fasti di casa Visconti raffigurati sulle pareti. Tra questi, fondamentale la vittoria di Desio sui Torriani, qui ricordata con l’immagine dello sconfitto Napo che implora pietà per sé e per la sua parte.


